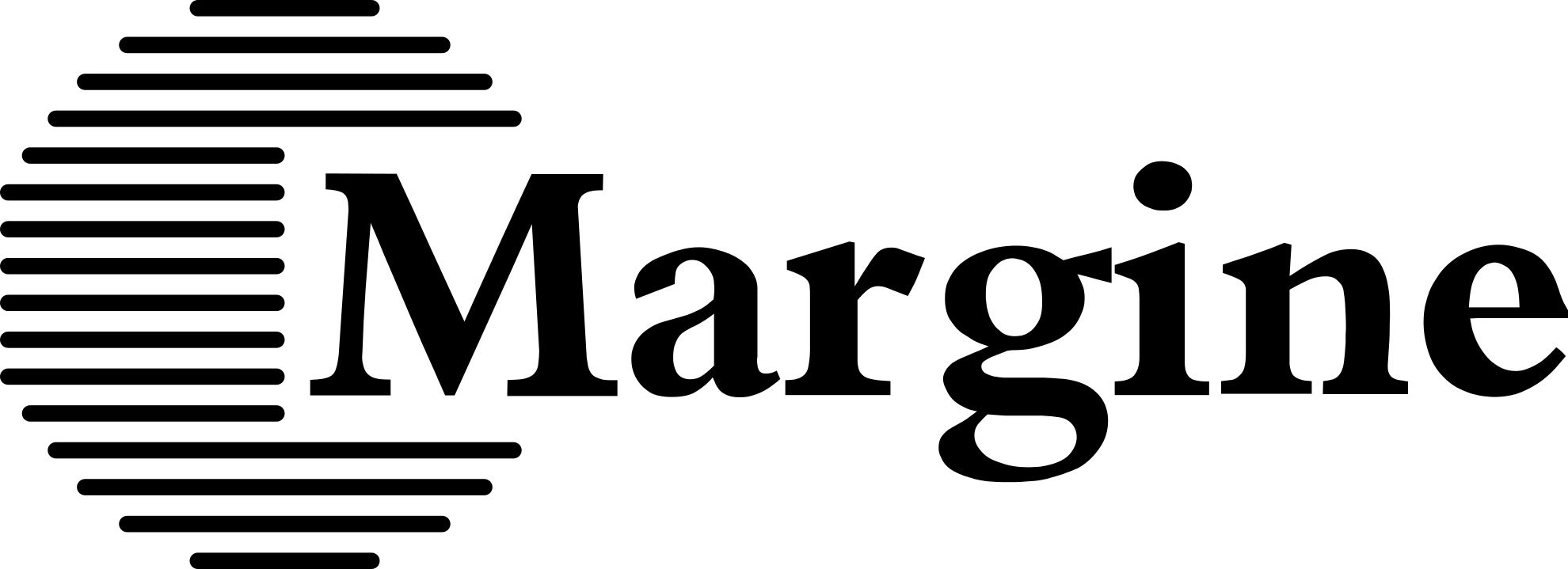Più presso a te, mio divano

Più presso a te, mio divano
I sette peccati capitali: L’accidia
Questa prosa di Thomas Pynchon è stata pubblicata sul New York Times Book Review il 6 giugno 1993. Il brano è il primo di una serie estiva che il quotidiano statunitense dedicò alla trasposizione letteraria dei sette peccati capitali. L’iniziativa coinvolse alcuni dei più influenti scrittori contemporanei, invitati a offrire una riflessione personale e laica sui vizi tradizionali. Il testo si colloca, quindi, in un dialogo intellettuale con altri importanti contributi della serie, tra cui Lust di John Updike, Anger di Mary Gordon, Avarice di Richard Howard e altri ancora. La serie completa di saggi è stata successivamente raccolta nel volume intitolato Deadly Sins (1993), curato da Mary Gordon, pubblicato in italiano nel 1994 da Rosellina Archinto Editore con il titolo Otto peccati capitali. La traduzione che segue è stata realizzata da Matteo Maci per Margine Rivista.
Nella sua trattazione classica dell’argomento all’interno della Summa Theologica, Tommaso d’Aquino definì l’accidia uno dei sette peccati capitali. Usò “capitale” nel senso di “primario” o “originario”, perché da questi peccati discendevano gli altri, ma un significato più cupo si annidava in questa parola, senza scalfire la potenza dell’argomentazione, dato che “capitale” può significare anche “punibile con la pena capitale”, o, per usare un’espressione più incisiva, “punibile con la morte”.
Ma sul serio, non vi sembra un po’ esagerata la condanna a morte per una cosa tanto lieve come l’accidia? Immaginate di essere rinchiusi in qualche braccio della morte medievalesco:
«Senti, non vorrei essere indiscreto, ma per cosa sei dentro?»
«Solita storia, sono arrivati al momento peggiore: ho sterminato mezza pattuglia dello sceriffo con la ma balestra da due cubiti, sparando raffiche di dardi da 20mm. Ira, credo… E tu?»
«Ehm, ecco… Non è per l’ira…»
«Ah! Un altro di quei casi di accidia, vero?»
«…in realtà, non è che abbia fatto qualcosa, io.»
«Va così, amico mio. Guarda, è quasi ora di pranzo. Non sarai mica uno scrittore, per caso?»
Gli scrittori sono naturalmente considerati i maestri dell’accidia. Vengono chiamati in continuazione a esprimersi sul tema, non solo per dare consigli, ma anche per parlare ai vari Simposi sull’accidia, per guidare Task Force anti-accidia, testimoniare in qualità di periti presso le Udienze sull’accidia. Lo stereotipo deriva in parte dal massiccio impiego di scrittori in professioni retribuite in base al numero di parole, con scadenze rigide e definitive: ci si aspetta che siamo esperti lavoratori a cottimo, sapendo che il tempo è denaro. Inoltre, c’è tutto quel fascino folcloristico riguardo il blocco dello scrittore, una sofferenza che a volte si risolve da sé in maniera drammatica e senza preavviso, un po’ come la stitichezza, e che (per questo?) gode di grande simpatia presso i lettori.
Il blocco dello scrittore è come una gita al tuo parco giochi preferito in compagnia del peccato mortale che lo crea. Come ognuno degli altri sei peccati capitali, l’accidia doveva essere la capostipite di una famiglia intera di peccati minori, ovvero veniali, tra cui l’oziosità, la sonnolenza, l’irrequietezza del corpo, l’instabilità e la verbosità1. “Acedia” in latino significa tristezza, deliberatamente auto-inflitta, quella che allontana da Dio, una perdita di determinazione spirituale che si rialimenta in un circolo vizioso e finisce per produrre ciò che oggi chiamiamo senso di colpa e depressione, che ci spingono a fare qualsiasi cosa, tra peccati veniali e giudizi errati, pur di evitare questo malessere.
Ma la progenie dell’accidia, per quanto cattiva (parafrasando le Shangri-Las2), non è sempre malvagia: è il caso, per esempio, di quella che Tommaso d’Aquino definisce “l’importunità dello spirito”, cioè la voglia di “importunamente effondersi sulle varie cose”, che, nel caso in cui “appartiene alle facoltà conoscitive, viene detta curiosità”3. È proprio durante episodi simili di viaggio mentale che gli scrittori sono noti per svolgere un buon lavoro, a volte persino meglio di ogni altra circostanza, dato che diventano capaci di risolvere problemi di forma, ricevendo consigli dall’Aldilà, oppure vivendo avventure ipnagogiche che, con un po’ di fortuna, possono essere riprese a posteriori. Sognare a occhi aperti è spesso l’essenza di quello che facciamo: vendere i nostri sogni. Così facciamo soldi grazie all’accidia, per quanto si dice che questa trasformazione sia più sbalorditiva in altri settori dell’intrattenimento, dove oziose opportunità di chiacchiere in piscina hanno generato, e non poche volte, incassi da decine di milioni di dollari.
Come tema per la narrativa, l’accidia riscosse un bel po’ di successo nei secoli successivi a Tommaso d’Aquino, ne è celebre esempio l’Amleto, ma solo una volta che sbarcò sulle coste americane, compì il passo successivo, fondamentale nella sua evoluzione. Tra l’aforista compulsivo di Franklin, il Povero Richard, e lo sventurato scrivano di Melville, Bartleby, c’è circa un secolo di America delle origini, impegnata a consolidarsi come stato capitalista cristiano, in un periodo in cui l’accidia stava completando il suo passaggio da condizione spirituale a secolare.
Philadelphia, ai tempi di Franklin, rispondeva sempre meno alla visione religiosa che ne aveva dato William Penn: la città si stava trasformando in una sorta di macchina ad alto rendimento, con materie prime e lavoro che entravano, beni e servizi che ne uscivano, mentre il traffico all’interno scorreva vivacemente in una griglia di isolati uniformi. Il labirinto urbano di Londra, che conduceva alla tentazione e anche al peccato, lì era stato geometricamente raddrizzato (Dickens, visitando la città nel 1842, scrisse: “Dopo aver camminato un’ora o due per le sue strade avrei dato tutto il mondo in cambio di una viuzza un po’ storta”4). Le questioni spirituali non erano tanto immediate quanto quelle materiali, come la produttività. L’accidia non era più percepita come un peccato contro Dio o contro lo spirito, ma contro una concezione particolare del tempo: uniforme, a senso unico, in generale irreversibile, ovvero contro il tempo dell’orologio, che metteva tutti a letto presto e altrettanto presto li svegliava.
Il Povero Richard non esitava a esprimere il suo disgusto per l’accidia. Quando non stava semplicemente ripetendo i soliti proverbi inglesi sul tema, lui ci metteva del suo con esplosioni retoriche in stile Grande Risveglio: “O Fannullone! Credi forse che Dio ti avrebbe dato braccia e gambe se non avesse voluto che tu le usassi?” Oltre l’andamento rubato5 del giorno, continuava a battere un ritmo severo e incessante, ineluttabile, spietato: ogni cosa evitata o rimandata doveva essere recuperata più tardi, e più intensamente. “Tu puoi indugiare, ma il tempo no.” E l’accidia, essendo un’evasione continua, continuava ad accumularsi come un deficit di bilancio, mentre le proporzioni della resa dei conti inevitabile si facevano sempre meno clementi.
Nell’idea di tempo che aveva iniziato a governare la vita delle città ai tempi del Povero Richard, in cui ogni secondo era volatile e di pari durata, non c’era molto nel suo scorrere che poteva essere definito non-lineare, a meno che non si consideri l’indomabile distorsione dei sogni, dei quali il Povero Richard non se ne faceva granché. Nella “Concordanza dei detti” del 1974 di Frances M. Barbour, non si trova niente sotto la voce “Sogni”, dato che in quei tempi a Philadelphia erano tanto sgraditi quanto il loro compagno abituale, il sonno, che era ritenuto tempo perso per accumulare ricchezza, tempo che doveva essere ridotto in modo da essere produttivi per 20 ore di veglia. Negli anni del Povero Richard, Franklin, secondo la sua Autobiografia, si concedeva di dormire dall’una del mattino fino alle cinque. L’altro lasso di tempo per non lavorare era di quattro ore, dalle nove di sera fino all’una, in cui si occupava della Domanda Serale, “Cosa ho fatto di buono oggi?” Questa sarà stata, nell’arco della giornata, l’unica occasione possibile per abbandonarsi alla fantasia; non sembravano esistere altri momenti per speculare, sognare, fantasticare o darsi all’immaginazione. La vita in quel meccanismo ortogonale doveva essere saldamente ancorata alla realtà.
Ai tempi di Bartebly lo scrivano: una storia di Wall Street (1853), l’accidia aveva perso ogni connotazione religiosa ed era considerata un crimine contro l’economia. Proprio nel cuore del capitalismo dei signorotti, il protagonista sviluppa quella che è, a tutti gli effetti, un’accidia incurabile, come in una di quelle storie western in cui il desperado continua a fare scelte che lo guidano verso un unico, discutibile finale. Bartebly se ne sta semplicemente seduto in un ufficio a Wall Steet a ripetere “Preferirei di no”. Mentre le sue opzioni si riducono rapidamente, il suo datore di lavoro, uomo d’affari e di sostanza, è costretto a mettere in discussione i fondamenti della propria vita a causa di questo miserabile scrivano (questo scrittore!) che, pur essendo l’ultima ruota del carro della società capitalista, si rifiuta di continuare a interagire con l’ordine quotidiano, sollevando così una domanda essenziale: chi è più colpevole di accidia? Una persona che collabora con la radice di ogni male, accettando lo stato delle cose in cambio di uno stipendio e del quieto vivere, oppure chi, in fin dei conti, non fa altro che persistere nella sua tristezza? “Bartleby” è la prima grande epopea dell’accidia moderna, a cui presto faranno seguito le opere di autori come Kafka, Hemingway, Proust, Sartre, Musil e altri: prendete la vostra lista di scrittori preferiti dopo Melville e sarete destinati, prima o poi, a imbattervi in un personaggio portatore di una tristezza riconoscibile come caratteristica del nostro tempo.
In questo secolo siamo portati a considerare l’accidia come una cosa principalmente politica, un fallimento della volontà pubblica che legittima l’introduzione di politiche distorte e l’ascesa di regimi spietati, con l’avanzata fascista degli anni ‘20 e ‘30 che ne sono forse l’apoteosi, per quanto gli anni del Vietnam e delle presidenze Reagan e Bush non siano poi tanto dissimili. Le opere di narrativa, e non solo, sono piene di personaggi che non riescono a fare ciò che dovrebbero a causa dello sforzo necessario. Come non vederci il nostro mondo? Occasioni per scegliere il bene ci si presentano spontaneamente sia nella sfera pubblica che nella vita privata, e noi le ignoriamo. L’accidia è il dialetto nella lingua morale di tutti i giorni. Sebbene non abbia mai perso le sue note più profonde di angoscia mortale, essa non raggiunge mai l’intensità della disperazione conclamata, né la sua concretezza, perché è disperazione a buon mercato, un deliberato allontanamento dalla fede in qualsiasi cosa a causa del disagio che la fede provoca quando si vuol perseguire le proprie voglie, ire e altri desideri quotidiani. Ultima difesa del pessimista compulsivo — stai fermo immobile e la lama della falce, in qualche modo, non ti colpirà — l’accidia è la nostra radiazione di fondo, la nostra trasmissione di fiducia: è ovunque, non ci si fa più caso.
Ogni discussione sull’accidia ai nostri giorni è sicuramente incompleta se non si considera la televisione, con il suo potere paralizzante, assieme alla sua creatura e simbionte, il famigerato Poltrone. I racconti intrecciati nell’ozio ci inquadrano davanti al televisore, supini, mangime per chiropratici, a risucchiare tutto, reiterando in senso opposto la transazione tra sogno e guadagno che in origine ha portato queste ombre colorate davanti ai nostri occhi, perché potessimo nutrircene acriticamente e, in parallelo, commettere gli altri sei peccati capitali: ingozzarsi, invidiare le celebrità, bramare i prodotti pubblicitari, eccitarsi con delle immagini, adirarsi per le notizie, perversamente fieri della distanza che separa il nostro divano da quello che appare sullo schermo.
Triste, ma vero. Eppure, in gran parte grazie all’invenzione provvidenziale (non è mai troppo presto!) del telecomando e del videoregistratore, forse c’è speranza, dopo tutto. Il tempo-video non è più la merce lineare e uniforme che era un tempo. Non quando si dispone della selezione istantanea dei canali, del tasto accelera e riavvolgi, e via dicendo. Il tempo del video può essere rimodellato a piacere. Ciò che ai tempi dell’antica amministrazione poteva sembrare tempo sprecato e irrecuperabile non è più, forse, strutturato in maniera così semplice. Se l’accidia può essere definita come la pretesa, nella tradizione del colonialismo americano e delle sue razzie, che il tempo sia un’altra risorsa infinita, messa lì per essere sfruttata in eterno, allora potremmo, almeno momentaneamente, aver trovato l’illusione, l’effetto di controllare, invertire, rallentare, accelerare e ripetere il tempo, immaginando persino di potervi sfuggire. I peccati contro il tempo-video dovranno essere ridefiniti in modo radicale.
Che una forma di cambiamento sia già in vista? Un numero recente del The National Enquirer ha annunciato il vincitore del concorso per il Re dei Poltroni, ovvero il più grande Poltrone di tutti gli Stati Uniti, scelto tra circa un migliaio di candidati. “Tutto quello che faccio consiste nel guardare la televisione e lavorare, ammette lo scapolo trentacinquenne che tiene accesi tre televisori 24 ore al giorno nella sua casa a Fridley, in Minnesota, e guarda un quarto televisore mentre è a lavoro.
“Non c’è niente che mi piace di più che starmene seduto con una cassa di birra, le patatine e un telecomando… Sono addirittura finito in televisione durante una sfilata di carri in paese. Sono entrati a casa mia, hanno preso il mio divano e lo hanno messo su un carro allegorico. Mi sono seduto sul divano in accappatoio e ho partecipato alla sfilata!’”
Va bene, ma questa può essere considerata davvero accidia? Il quarto televisore sul posto di lavoro, il fatto che questo maniaco del televisore abbia ricordato per due volte il fatto di starsene seduto e non sdraiato, suggeriscono qualcosa di diverso. Scorrere tra i canali e manovrare il videoregistratore potrebbero richiedere un coinvolgimento più attivo di quanto non sia consono per il venerabile peccato dell’accidia: una certa prontezza o tensione interiore, come quella di qualcuno che fa yoga o meditazione Zen. Che l’accidia stia per essere, ancora una volta, in qualche modo trascesa? Un’altra possibilità, ovviamente, è che non l’abbiamo affatto superata, ma che si sia semplicemente ritirata dal suo posto più familiare, la televisione, e stia cercando di insinuarsi in altri ambienti oscuri, chissà? Videogiochi, sette religiose, palazzi della borsa di città lontane, pronta a riapparire in una nuova forma per darci disperazione cosmica a buon mercato.
A meno che lo stato delle nostre anime non torni a essere un motivo serio di preoccupazione, non c’è dubbio che l’accidia continuerà ad allontanarsi dalle sue lontane origini, fatte di fede e miracoli, quando nella vita di tutti i giorni lo Spirito Santo era davvero all’opera e il tempo era una storia, con un inizio, uno svolgimento e una fine. Tempi di fede intensa, e duro lavoro; il Dio cristiano era vicino, lo si sentiva. L’accidia, l’insolente tristezza davanti alle buone intenzioni del Signore, era un peccato mortale.
Forse il futuro dell’accidia consisterà nel peccare contro quello che al momento sembra definirci sempre di più: la tecnologia. Resistendo da tristi luddisti, nonostante le buone intenzioni della tecnologia, ce ne staremo seduti con la testa nella realtà virtuale, rifiutando tacitamente di essere assorbiti dalle sue inutili fantasticherie usa e getta, anche le spensierate quanto letali disavventure che vedono dei supereroi alle prese contro i supercattivi senza scrupoli del caro vecchio Team Accidia.
cfr. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, p. 3458. Traduzione di P. Tito S. Centi. [NdT] ↩︎
Riferimento a un verso della canzone “Give Him a Great Big Kiss” del 1964, del gruppo pop statunitense The Shangri-Las. [NdT] ↩︎
cfr. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, p. 3459. Traduzione di P. Tito S. Centi. [NdT] ↩︎
C. Dickens, America, Feltrinelli Editore, 2022, p. 164.Traduzione di Maria Buitoni, Gianfranco Corsini e Gianni Miniati. [NdT] ↩︎
In italiano nel testo, in riferimento all’indicazione sul ritmo presente nelle partiture musicali. [NdT] ↩︎
Ti potrebbe interessare anche: permalink